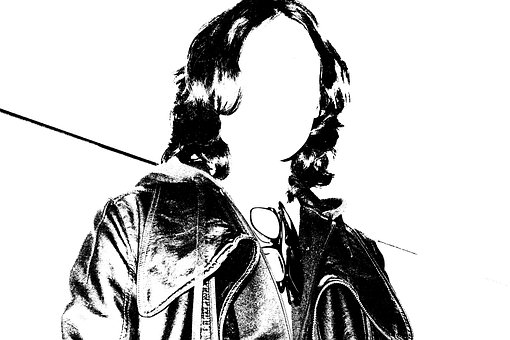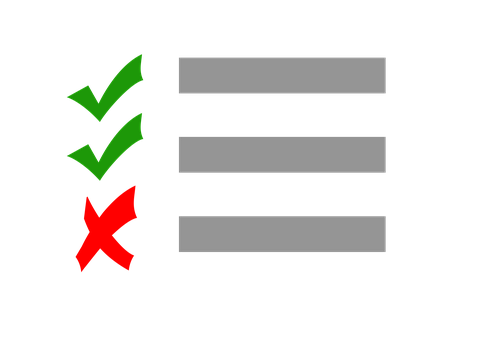
Qualche giorno fa abbiamo dato conto della pronuncia 3133/2019 della Corte di Cassazione che ha confermato il licenziamento di una dipendente per eccesso di Facebook. Oggi la sentenza è disponibile sul sito della Cassazione e possiamo commentarla più specificatamente rispetto agli eventuali contenuti di novità con riferimento a quanto sinora la dottrina e la giurisprudenza hanno sinora stabilito in materia di riservatezza dei lavoratori dipendenti.
In realtà, la sentenza non porta nulla di nuovo perché la dipendente aveva fondato il suo ricorso in Cassazione sui seguenti motivi:
- reputava tardivi e, quindi, inutilizzabili alcuni documenti prodotti in primo grado dal datore di lavoro dopo la rituale costituzione in giudizio; i giudici della Suprema Corte hanno respinto questa doglianza perché i documenti si erano formati dopo la costituzione in giudizio e, quindi, potevano correttamente “entrare in ritardo” nel giudizio come elemento di novità pertinente;
- ipotizzava che la Corte d’Appello non avesse tenuto nella dovuta considerazione la sua contestazione della cronologia di navigazione (dalla quale emergeva la frequentazione di Facebook) portata come prova dal datore di lavoro; la Corte di Cassazione non ha nemmeno esaminato la questione dicendo che, in sede di ricorso per Cassazione, doveva specificare “dove e come” avesse contestato tale elemento negli atti d’appello;
- riteneva l’accesso alla cronologia di navigazione, da parte del datore di lavoro, una violazione della privacy; gli ermellini hanno rilevato che questo argomento non era mai stato sollevato negli altri gradi di giudizio e, quindi, non poteva essere giudicato da loro.
Prova e riprova, ricordando, tuttavia, che il giudizio della Cassazione segue regole ferree.